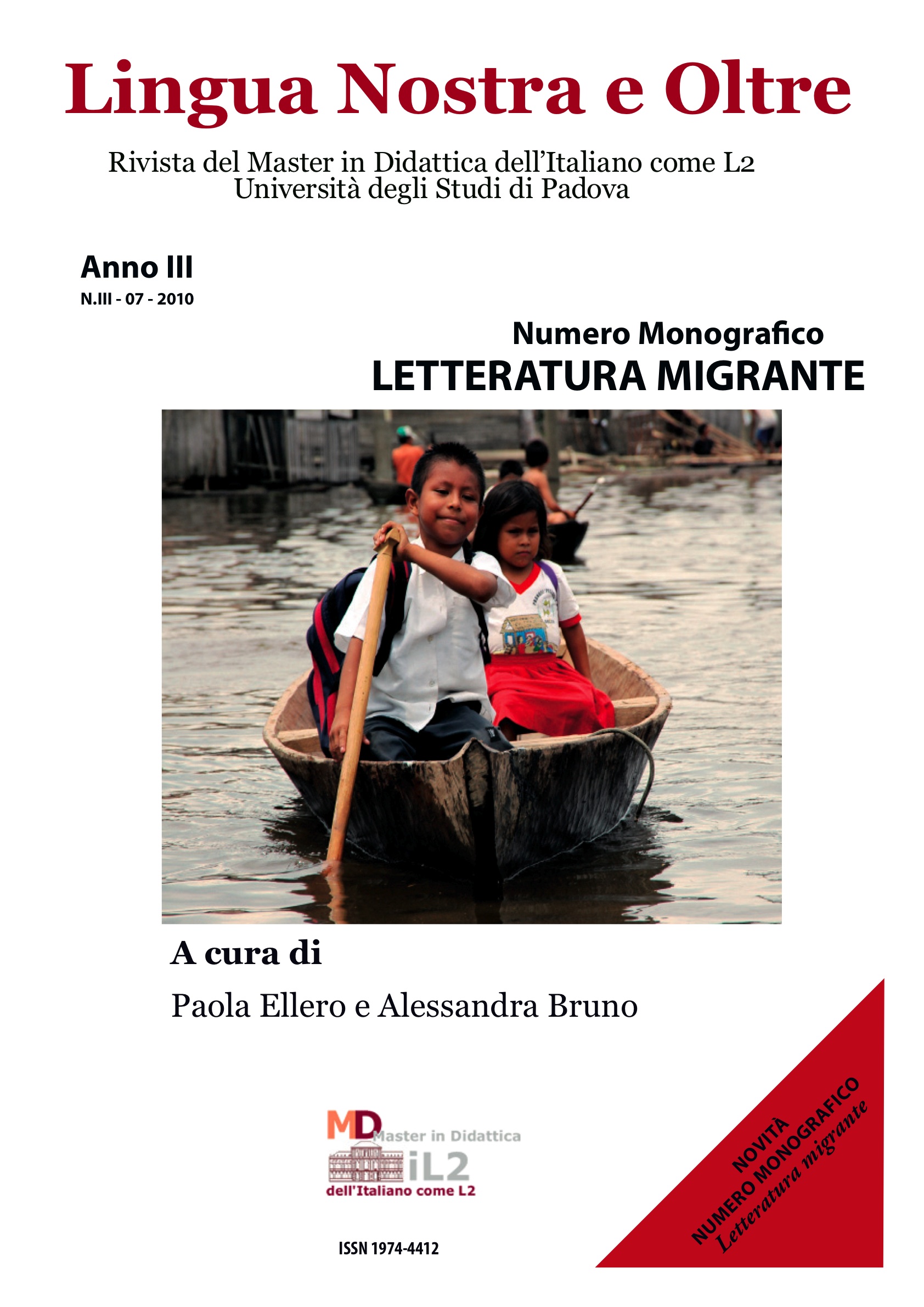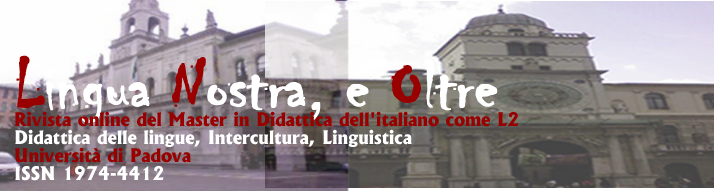
|
Anno III - N.3/2010
|
Editoriale
di
Maria G. Lo Duca
Questo
numero monografico della rivista, interamente dedicato al tema della letteratura
migrante in Italia, ha due obiettivi prioritari.
Il primo è quello di contribuire a chiarire le nostre e le vostre
idee su un universo tanto vasto quanto, ai più, sconosciuto, raccogliendo
materiali e diffondendo tra i nostri lettori conoscenze relative al mondo
dell’immigrazione. Più precisamente, questa volta il nostro
interesse si è concentrato sui risvolti diciamo così più
‘culturali’ di questo straordinario incontro di popoli che
si è realizzato nel nostro paese negli ultimi due decenni, e che
diventerà sempre più, a dispetto di qualunque governo e
di qualunque provvedimento legislativo, la realtà italiana: una
realtà multietnica, quindi multiculturale. Di questo incontro –
che, ahimé, talvolta diventa scontro aperto, intollerante, xenofobo
– noi non abbiamo paura. E non abbiamo paura perché proviamo
a conoscere e capire le ragioni di chi, per i motivi più diversi
ma certo sempre dolorosi, ha deciso di stabilirsi nel nostro paese, temporaneamente
o stabilmente, e prova a vivere e lavorare dignitosamente, arrivando perfino
a cimentarsi con la scrittura in lingua italiana, e in lingua italiana
racconta storie, sogni, emozioni. Noi abbiamo letto queste storie, i nostri
giovani corsisti del Master le hanno analizzate, ne hanno tratto notizie
e informazioni preziose, ma non solo. I testi degli scrittori migranti,
sia che si vendano in libreria sia che ci vengano offerti agli angoli
delle strade, hanno rivelato altre facce, altri aspetti del popolo migrante,
che ce lo hanno fatto sentire più vicino, perché, guarda
caso, impastato della stessa ‘materia’ nostra, degli stessi
nostri ‘umori’. Questo numero della rivista vuole dunque dire,
prima di tutto, che a questa umanità noi riconosciamo la stessa
dignità che riconosciamo a ciascun essere umano, e che con questa
umanità noi abbiamo voglia di continuare a dialogare.
Il secondo obiettivo può apparire più modesto rispetto al
primo, ma solo apparentemente. Ho già detto che gli autori (ma
in realtà si tratta di autrici) dei diversi pezzi sono giovani
corsisti del Master, che hanno deciso di svolgere la loro tesi di fine
corso su questo tema, guidati e sorretti dalla docente di Comunicazione
Interculturale, prof.ssa Paola Ellero. Come si vedrà, gli interventi
affrontano il tema da angolature diverse, senza mai dimenticare però
che il percorso di studio seguito mira a costruire un profilo professionale
preciso: che non è quello dell’operatore interculturale,
ma quello dell’insegnante di lingua italiana, seconda o straniera,
operante in Italia o all’estero, e questo obiettivo finale non è
mai stato dimenticato. Anche in questo caso opera una forte convinzione:
che non c’è incontro di culture senza incontro di lingue.
E come si potrebbe dialogare senza una lingua in comune? I gesti, le posture,
le tonalità – che pure hanno tanta parte nei nostri scambi
quotidiani – hanno comunque una portata semantica elementare, e
sono per lo più insufficienti a veicolare i contenuti più
‘fini’. Da qui l’attenzione costante per il risvolto
didattico del tema, e il tentativo di trasformare questi materiali in
occasioni motivanti di insegnamento/apprendimento dell’italiano,
in unità didattiche, attività, esercizi. Noi vogliamo, infatti,
che i nostri giovani escano dal Master non solo con le idee chiare in
fatto di intercultura, ma anche con un bagaglio tecnico preciso –
fatto di conoscenze disciplinari e competenze operative – adeguato
alle nuove sfide. Questo secondo obiettivo è dunque, come si vede,
non meno ambizioso del primo.
Infine: questo numero della rivista, ideato e curato da una corsista del
Master, la dott.ssa Alessandra Bruno, vuole essere anche un esperimento
didattico. È, infatti, la sua tesi di fine corso, il lavoro conclusivo
che ogni corsista deve compilare sotto la supervisione di un docente,
nel caso specifico la prof.ssa Paola Ellero, e che poi deve discutere
con una commissione di docenti. A me pare un esperimento riuscito. Con
l’aggiunta che in questo caso particolare a giudicare saranno non
solo i docenti chiamati a far parte della commissione, ma anche gli sconosciuti
lettori che avranno voglia di leggere e condividere con noi questa esperienza.
![]()
Copyright 2010 - Master in Didattica dell'Italiano come L2 - Dipartimento di Romanistica - Università degli Studi di Padova
Ultimo
aggiornamento il 29 luglio 2010